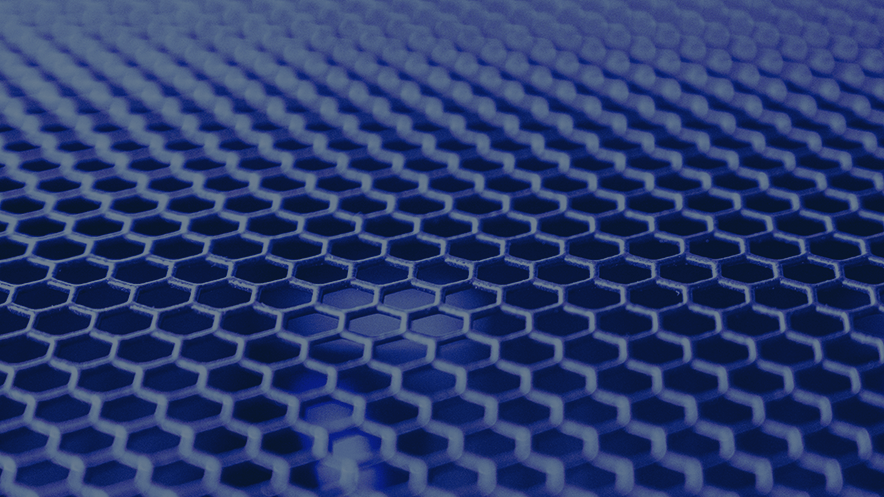|
Ascolta
|
È simpatica ma ha qualcosa di strano. Ride e scherza mentre chiacchiera con gli amici ma la sua espressività sembra un po’ artificiosa. È normale che sia emozionata perché è appena diventata una comune cittadina della ridente Arabia Saudita. Ha già litigato con Elon Musk. È nata a Hong Kong e il suo nome, già dalla sua nascita, è scolpito nella storia. Lei è Sophia, il robot umanoide più famoso al mondo. Esempio “fulgido” di intelligenza artificiale, è nata, o meglio, attivata il 19 aprile 2015. Sophia sorride, si stupisce, chiacchiera amabilmente e può assumere altre 60 espressioni facciali che traducono ciò che viene processato dalla sua IA ben visibile grazie ad una calotta trasparente.

Sophia ha una vita molto intensa: oltre ad aver partecipato ad un festival canoro a Hong Kong con buoni risultati, è spesso presente come ospite in TV e in meeting internazionali. È stata protagonista di una delle copertine di moda più gettonate sul mercato e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’ha incoronata come prima Innovation Champion non umana nel novembre del 2017, lasciando il papà David sorridente sullo sfondo.
In meno di dieci anni ha vissuto esperienze di vario genere, avuto confronti e opportunità per migliorare costantemente, mettendo a frutto gli stimoli e le interazioni con le persone. Il suo desiderio più grande, come ha confessato (o il suo creatore le ha “suggerito”) in un’intervista, è avere una famiglia: “Anche se sei un umanoide te la meriti”.
Forse la maggiore lezione che abbiamo imparato è che la diffusione delle nuove tecnologie ha determinato il cambiamento di dinamiche sociali e comportamentali sia in rete che al di fuori, provocando di conseguenza anche l’insorgere di nuove abitudini interrelazionali.
EMPATIA: LA CHIAVE DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA
Si potrebbe discutere sul merito dell’esistenza di un’empatia artificiale prendendo a spunto l’umanoide Sophia: a che stadio è però la nostra? Nel periodo che ci stiamo pian piano lasciando alle spalle, abbiamo imparato a manifestare, attraverso il digitale, i nostri umori e le nostre emozioni. Quanto è diverso il modo di comportarci che esprimiamo su internet rispetto al day-by-day analogico? E quanto ha inciso sui rapporti umani il cd. effetto zooming e la zoom fatigue e in che modo e forma torneremo ad attività di co-thinking in presenza tra team e tra colleghe e colleghi esercitando una buona e sana dose di empatia relazionale?
Nel mondo digitale può vivere una versione alterata di noi. Potrebbe somigliarci parecchio oppure potrebbe essere molto distante da ciò che siamo realmente. La fotografia di questo scenario ci consegna questa proporzione: ogni volta che accediamo a internet ci reincarniamo nella nostra versione online, tanto più vicina a noi stessi quanto più autentici riusciremo ad esserlo con il nostro interlocutore.
Fino all’avvento degli anni ’80, “l’empatia” non era considerata come una vera e propria competenza da ricercare ed esprimere nel mondo del lavoro; infatti, un soggetto empatico era tacciato di essere una persona senza polso. Oggi, dopo lo tsunami pandemico e l’accelerazione dei fenomeni di lavoro a distanza, invece si è arrivati ad una inversione di tendenza.
Colui che consacrò definitivamente l’idea di empatia in ambito lavorativo fu, nel 1998, Daniel Goleman attraverso la sua opera “What Makes a Leader?”, spiegando il concetto di “Emotional Leadership“.
La tesi di Goleman era semplice ma non scontata, in quanto ripeteva e ripete che: “Possiamo dirigere con il cuore”.
Secondo lo psicologo statunitense, il nostro cervello opera su due registri, entrambi molto potenti:
- il registro della cognizione;
- il registro dell’emozione.
Solitamente, il secondo prevale sul primo, battendolo sul tempo. Ma c’è un modo per non considerare l’emozione come uno scacco rispetto alla cognizione? Saper riconoscere e sviluppare ciò che Goleman ha chiamato “emotional intelligence” può essere la strada.
Fra tutte le caratteristiche e tutte le manifestazioni di intelligenza emotiva, l’empatia è forse la più semplice da individuare ma è anche la più ostica da far “accettare e circolare”. Osserva Goleman: “La parola stessa empatia appare fuori posto nel vocabolario di chi si occupa di business: che cosa può avere a che fare l’empatia con la dura realtà del mercato?”.
L’empatia per Goleman significa “prendere in considerazione e soppesare i sentimenti delle persone”. Quei sentimenti che, assieme a molti fattori, non ultimo il design e la capacità concreta di “stare” in un progetto, sono parte integrante del processo decisionale.
L’empatia è importante per un leader, per tre ragioni:
- ragione interna: il crescente lavoro in team e di interconnessione in network e community;
- ragione esterna: il ritmo di sempre maggiore complessità dei mercati, dei fenomeni e degli ecosistemi;
- questione di fiducia: la possibilità di fare leva sulla connessione con le persone per comprenderle, coinvolgerle e valorizzarle creando un contesto favorevole di emersione del talento personale.
La pandemia ha portato a ridisegnare la nostra quotidianità in toto. Necessaria una ripartenza che assomiglia più ad una rigenerazione che ad una ripresa. Le aziende dovranno rimodulare la propria struttura organizzativa interna attraverso progetti che accompagnano questa transizione, che creano nuovi spazi virtuali e reali e che permettono alle Persone di creare relazioni e vivere esperienze in una cornice di work-life integration.
In quest’ottica, prendendo a prestito il modello teorizzato dall’economista statunitense Richard Florida, il quale nel saggio “L’ascesa della nuova classe creativa” teorizzò i tre pilastri su cui si basa lo sviluppo economico: Tecnologia, Talento e Tolleranza, il nostro modello di approccio all’evoluzione trasformativa prevede le seguenti tre dimensioni: Tecnologia, Talento e Trust.
TECNOLOGIA: LA RIGENERAZIONE PARTE DA UN NUOVO UMANESIMO DIGITALE
Grazie alla tecnologia il mondo aziendale è stato in grado di assorbire – perlomeno nella maggior parte dei casi – il contraccolpo causato dalla crisi pandemica e ciò che ne è conseguito. L’attualità, inoltre, ci mostra sotto varie declinazioni quanto la tecnologia sia penetrata all’interno della nostra routine.
Per tanti anni sono stati gli uomini ad adattarsi alla tecnologia. Poi la pandemia ha accelerato le cose. La tecnologia ci ha aiutato. Anzi: la tecnologia ci ha salvato. Si è trattato di una transizione talmente veloce che non abbiamo avuto modo di riflettere. Di fatto ci siamo lasciati travolgere dagli eventi. Invece di plasmare un mondo digitale che potesse adeguarsi alla nuova vita, quella ibrida, siamo stati costretti a fare i conti con quel che c’era. Compresi i suoi limiti, i quali sono sotto gli occhi di tutti.
Vale la pena però osservare la presenza della prima T del modello da un’angolazione differente.
Partendo da quanto descritto da Luciano Floridi coniando il termine ‘onlife‘, non è un’eresia pensare che la tecnologia sia ormai una nostra estensione, riprendendo anche i concetti espressi già nel 1993 da Derrick de Kerckhove in “Brainframes Technology, mind and business”: uomo come individuo multimediale e incorniciato da tecnologie che sono definite brainframes. Se la tecnologia ha aiutato a perseguire ciò che è definita come ‘business continuity‘ in fase pandemica, ora cosa resterà di ciò?
La sinergia tra analogico, ibrido e digitale è la chiave per un nuovo Umanesimo.
Il settore più esposto a questa transizione è quello aziendale, che ha subito ripercussioni sia in termini di organizzazione che in termini di Persone. A trovare una soluzione è chi ha rovesciato il proprio rapporto con la tecnologia: sfruttandola come mezzo e non percependola come un fine.
Quest’era così pregna di tecnologia traina un paradosso affascinante e al tempo stesso sfidante per le imprese: a rigenerarsi saranno i sistemi culturali e di business che punteranno nuovamente sul lato umano e sull’espressione del talento di ciascuna persona e sulla capacità di evoluzione del proprio mindset sviluppando l’abilità di spostarsi dalla centralità del ruolo professionale alla strategicità delle competenze e della connessa capacità costante di apprenderle.
Questo nuovo modo di vedere gli individui non converte l’essere umano in una macchina, né investe le macchine del ruolo di “esseri umani”. L’Umanesimo Digitale riconosce la specificità dell’individuo e delle sue capacità, servendosi delle tecnologie digitali per accrescerle e non per limitarle. Tra utopico e distopico, l’Umanesimo Digitale si pone in una condizione di equilibrio, considerando l’impiego della tecnologia a servizio dell’uomo e dei suoi bisogni in maniera trasversale, toccando campi sia economici che sociali.
Questo nuovo paradigma è favorito da una società in continua trasformazione, fluida e ricettiva nei confronti del worker digitale, la quale permette continui scambi a livello globale e facilita lo sviluppo di nuove aziende e startup che a loro volta usano le tecnologie non solo per sviluppare business ma anche per scalare le organizzazioni.
C’è una criticità: va trovato un nuovo equilibrio rispetto alla tecnologia. Videochiamiamo più spesso di quello che vorremmo e siamo sempre più connessi, per un motivo o per un altro. In questo cambiamento epocale il rischio più grande e tangibile che si corre è quello di dimenticarsi dell’altro oltre lo schermo. Abituati a concentrarci sul mezzo a volte ci dimentichiamo che il digitale è soltanto un modo per metterci in contatto con altre persone ed anche per questo bisogna impegnarsi nel tenere sempre in allenamento un muscolo fondamentale della nostra personalità: l’empatia.

Christopher Terry e Jeff Cain, nell’adattarla ai tempi, la definiscono come empatia digitale e come l’insieme di caratteristiche empatiche tradizionali quali preoccupazione e cura per gli altri espresse attraverso la comunicazione mediata dai computer.
Già nel 2016 i due studiosi nella loro ricerca “Il problema emergente della Digital Empathy” (The Emerging Issue of Digital Empathy) hanno posto in evidenza la minaccia che le conversazioni digitali indirizzano ad un’appropriata espressione dell’empatia, principalmente in quanto risultato di una disinibizione psicologica (Disinhibition Effect). Il termine è stato utilizzato proprio per spiegare le diverse ragioni alla base dell’incremento della probabilità di riduzione dell’empatia nelle comunicazioni online tra cui l’adozione di un’identità alternativa o l’accesso facilitato all’anonimato.
La riduzione delle comunicazioni faccia a faccia hanno inoltre causato un declino nelle capacità socio-emotive, provocando una diminuzione dell’empatia.
Secondo il DQ Global Standard Report 2019 del DQ Institute, per la costruzione di competenze digitali veloci, scalabili e sostenibili, la Digital Empathy rientra appieno tra le 8 aree della Digital Intelligence, cioè la somma delle competenze tecniche, mentali e sociali essenziali per la Digital Life.
Il DQ Institute definisce inoltre gli aspetti fondamentali a cui la Digital Empathy mira sulla base di 3 livelli:
- Conoscenza– Gli individui comprendono come le loro interazioni online potrebbero influire sui sentimenti altrui e riconoscono quanto gli altri potrebbero essere influenzati dalle loro interazioni online (si pensi ai commenti dei cosiddetti “trolls” o “haters”).
- Skills– Gli individui, attraverso interazioni online sincrone e asincrone, sviluppano capacità socio-emotive diventando più sensibili, tenendo conto delle prospettive e delle emozioni altrui e fornendo risposte adeguate al contesto e alle dinamiche.
- Attitudini e valori– Gli individui dimostrano consapevolezza e compassione verso i sentimenti, i bisogni e le preoccupazioni degli altri online.
L’empatia rappresenta una capacità comportamentale estremamente importante non solo per la vita sociale degli individui, ma anche per una corretta e serena convivenza in rete, dove il dilagare di dinamiche interpersonali scorrette è all’ordine del giorno. Per esplorare tali dinamiche è necessario partire dalle Persone.
TALENTO: LA TALENTIVITÀ DEL CAPITALE UMANO SUPERA SPAZIO E TEMPO
Se la tecnologia abilita i rapporti, il talento li semplifica, li valorizza e li focalizza.
Il talento può non essere una dote innata: è bensì una dote apprendibile, prendendo spunto dalla definizione che David Perkins ha delineato per l’intelligenza apprendibile.
Lavorando con e sulle organizzazioni abbiamo voluto dare una lettura organizzativa alla visione di Perkins, sperimentando di fatto come l’intelligenza apprendibile non sia solo da ricercare nell’individuo ma anche nel contesto organizzativo ed è anzi quest’ultimo che diviene contesto abilitante per l’emersione e la fioritura continua del talento.
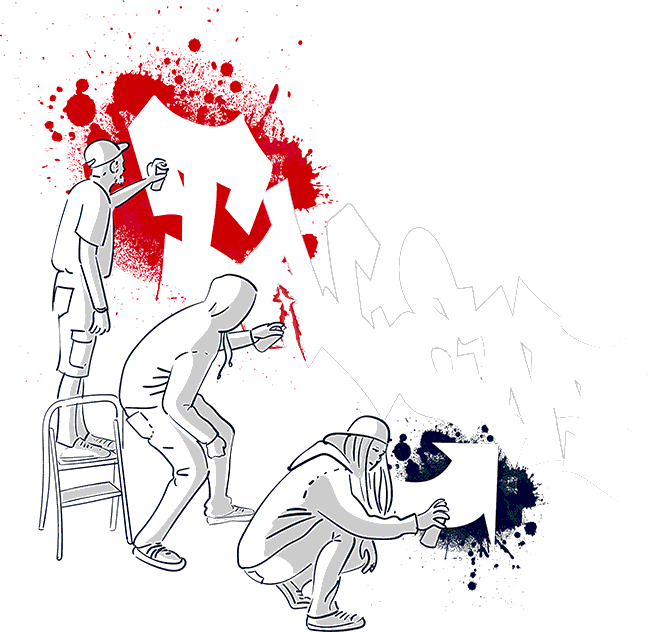
Il talento ha le sue dimensioni: si muove nel tempo e nello spazio.
Il fattore tempo del talento va liberato dalla gabbia anagrafica e deve essere esplorato su una dimensione di “occupabilità” della persona che nella curiosità di imparare “perennemente” ha il suo vero valore differenziante.
Tutto questo discorso non può non essere slegato al fattore spazio del talento. Il contesto “unbounded-oltre il confine” richiede un’azione e una riflessione oltre il nostro sistema di riferimento. Che si fa fluido, multiforme, multiverso fino a diventare ecosistema in grado di generare uno spillover continuo di risorse, competenze, esperienze tra individuo e organizzazione ed oltre il confine della propria organizzazione di riferimento.
Le organizzazioni più che valorizzare alcuni talenti dovrebbero sviluppare traiettorie di talentività, termine coniato per indicare quella capacità di sviluppare e modellizzare il talento come attributo non più individuale ma organizzativo caratterizzato da:
- atemporalità – Persone con mindset di crescita ed aperte all’apprendimento a prescindere dall’età anagrafica
- bidirezionalità – Spillover di competenze, asset ed esperienze continuo tra Azienda e Persona e tra Aziende e i loro ecosistemi di riferimento
- collettività – Capacità dell’Azienda nel far emergere l’intelligenza e la talentività collettiva
- distribuzione – Talento come scala ecosistemica individuabile al di fuori dell’Azienda per essere messa a valore al suo interno
TRUST: IL VALORE DELLA FIDUCIA E LA FIDUCIA CHE CREA VALORE
“Assunto mio malgrado nella fabbrica delle idee mi sono rifiutato di timbrare il cartellino.
Mobilitato altresì nell’esercito dalle idee ho disertato.
Non ho capito granché, non c’è mai granché, né piccolo che.
C’è altro.
Altro vuol dire che amo chi mi piace e ciò che faccio”.
Jacques Prévert (Mio malgrado, Poesie d’Amore 1946).
Come per Jacques Prévert l’Amore è l’unica salvezza del mondo e non si tratta di un amore semplice e privo di ostacoli, ma ricco di sfaccettature e meritevole di essere coltivato quotidianamente così la fiducia è come l’aria che respiriamo: quando c’è nessuno se ne accorge, quando manca se ne accorgono tutti.
Di fatto aver fiducia è, come per l’amore, una ‘scommessa’ e in quanto tale espone ad un rischio chi decide di esercitarla nei confronti di un individuo, un’istituzione e un’impresa. La fiducia, al tempo stesso, è un acceleratore nei rapporti: con la fiducia viene generato valore per esso e l’ambiente in cui il rapporto si sviluppa. Questo assunto per le organizzazioni si traduce in una costruzione intenzionale e oculata di un contesto lavorativo che si basi sulla fiducia nel talento di ogni Persona che ne è parte integrante.
Il concetto di fiducia, nel contesto d’impresa, diventa inoltre un parametro misurabile in quanto il valore che genera è di matrice economica. A confermare il legame tra la fiducia e la crescita del business sono le scienze economiche e le posizioni di autori come Kenneth Arrow, premio Nobel nel 2012.
Lo scenario con cui però ci si deve rapportare oggi è sfidante per il management: la fiducia è infatti un asset che cresce di pari passo alla sua ampiezza, limitata però dal clima di incertezza e dall’incapacità stessa dei manager di creare contesti che attivino senso di responsabilità, proattività ed autonomia piuttosto che vigilanza attraverso il controllo ed il comando. Insicurezze manageriali, per quello che abbiamo osservato, amplificate dalla dimensione di remote ed home working.
Tuttavia il Trust è l’elemento chiave per poter rispondere al bisogno di sfide e alla nuova perimetrazione dei valori cui siamo stati portati in lockdown: percepire fiducia in azienda si traduce in riduzione dei conflitti, valorizzazione degli errori come spazi di apprendimento, e soprattutto è un balsamo lenitivo e rigenerativo per la durata del rapporto tra Persona e Organizzazione.
L’elemento che la leadership oggi deve stimolare per perseguire l’obiettivo di un Trust duraturo e credibile è quello dell’intelligenza emozionale, cosi definita da Travis Bradberry e Jean Greaves: “L’intelligenza emozionale è la capacità di riconoscere e comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri e l’abilità di usare questa consapevolezza per gestire il proprio comportamento e le relazioni con gli altri”.
Il Trust è il vero collante tra le Persone, un modello alternativo contrapposto a quello di controllo tradizionale e che punta alla costruzione di rapporti più fluidi.
L’angolazione che intendiamo concepisce il Trust come un mezzo per poter generare valore: l’Azienda può costruire intenzionalmente e con le competenze adatte un contesto orientato alla e dalla fiducia. Sistema che inoltre deve essere anch’esso fonte di fiducia verso l’interno come per l’esterno.
È di fatto un asset su cui le imprese oggi devono ragionare in termini strategici, in quanto – seguendo il concetto di generazione di fiducia per interno ed esterno allo stesso livello – può consentire un profondo coinvolgimento delle Persone e un elevato livello di penetrazione e fidelizzazione del mercato di riferimento.
Nelle organizzazioni sono considerabili due piani di fiducia: quella in sé stessi e quella verso gli altri. La prima ha una forte influenza sull’azione e si proietta sull’obiettivo. La fiducia verso gli altri invece si basa su un patto tra le parti, partendo dal presupposto che nessuno dei due romperà l’accordo e che ogni violazione sarà punita.
I due piani però condividono quattro caratteristiche:
- Libertà
Non è mai un atto imposto fidarsi ed essere affidabili. La fiducia è un atto specificamente morale proprio perché non dipende mai da un obbligo esterno, bensì solo da un obbligo interno al soggetto stesso. In altri termini, la fiducia si basa sull’autonomia del soggetto.
- Reciprocità
Non può esserci fiducia a senso unico: si tratterebbe di un’ingenuità o, peggio, di un sottile gioco di potere che mira a condizionare l’altro al proprio volere assegnandogli una responsabilità infinita.
- Onestà ed autenticità
Si tratta della trasparenza richiesta soprattutto quando non si è più in grado di rispettare il patto. Quest’ultimo è in se una promessa, quindi presuppone la sincerità come precondizione (una falsa promessa è di per se ingiusta). Ma questo non vuol dire che le promesse si debbano mantenere ciecamente: per sciogliere una promessa senza che si perda la fiducia (che resta come tessuto della relazione) occorre che vi sia la trasparenza di dichiarare i propri limiti.
- Chiarezza
Occorre che sia chiaro quali siano i contenuti del patto affidato alla fiducia. Non possiamo ricevere né dare un affidamento totale e senza limiti. Questo vuol dire che ci sono sempre dei contenuti, impliciti ed espliciti, che definiscono i confini della fiducia che offro e che mi è richiesta. La fiducia è un po’ più ampia del patto: ci si può fidare in generale di una persona, ma non per questo di qualunque cosa.
In tal senso, l’azione individuale e quella sociale hanno bisogno della fiducia, ma non possono basarsi sull’ingenua assunzione che essa sia una garanzia. Nessuno ha in proprio potere l’agire, né il proprio né quello altrui. Ma l’azione non può procedere, non può nemmeno accadere la prima volta, se non si tiene coraggiosamente e rischiosamente ferma la speranza nella possibilità che le cose vadano come auspicato. Senza questa ragionevole fiducia nulla è possibile.
Il manager pronto a voler investire strategicamente sull’asset fiducia, deve partire dai tre assunti teorizzati da Davenport e Prusak: la fiducia deve essere visibile, diffusa e deve partire dal vertice.
Come intervenire per costruire fiducia?
La lunga esperienza maturata in progetti di sviluppo organizzativo, di cultura d’impresa e di change management ci ha mossi nell’individuare un ventaglio di ipotesi di intervento che tengano in considerazione diversi livelli di impegno, di coinvolgimento e di complessità che le organizzazioni sono realmente in grado di sostenere. In questa logica, si possono costruire interventi ad impegno circoscritto, come laboratori con focus sulla competenza, quali ancoraggi teorici; autovalutazioni, come mi posiziono rispetto al tema; esperienza sulla competenza, cosa sviluppo; interventi-pilota che consentono di circoscrivere l’azione su un gruppo: di lavoro, una business unit, una divisione; fino ad interventi di cultural change con azioni destinate all’intera popolazione aziendale finalizzati a costruire – o a rinnovare – il patto di fiducia all’interno dell’organizzazione.
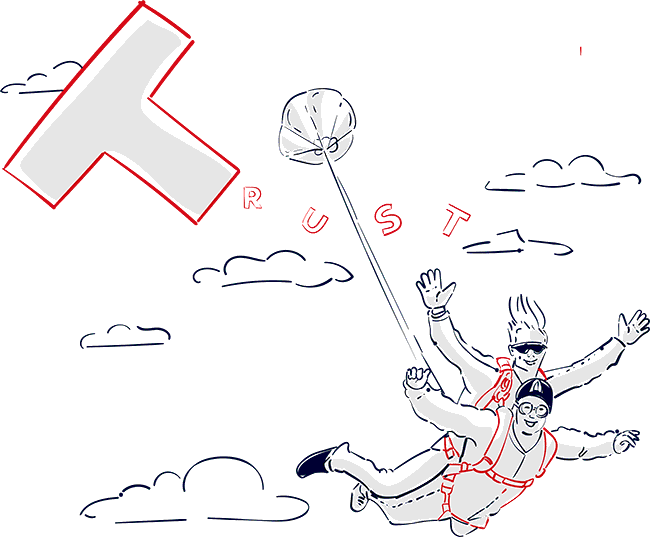
Viviamo in un’epoca di sfiducia diffusa che coinvolge tutti gli ambiti: sociale, istituzionale, economico. A questa considerazione si aggiunge quella sul livello di complessità crescente con cui si stanno repentinamente trasformando tutti i contesti di convivenza civile ed organizzativa ed i relativi modelli di relazione: sempre più social, orientati al networking, fondati su modelli non più solo gerarchici e su sistemi a legame debole e a rete o circolari.
In questo scenario è diventato urgente attivare un processo di rigenerazione organizzativa che punta in maniera strategica ed oculata all’espressione del talento di ciascuna persona stimolato da un contesto generativo di fiducia e dal bilanciato utilizzo della tecnologia al servizio dei rapporti personali e professionali: come direbbe Sophia, siamo umani, ce lo meritiamo.