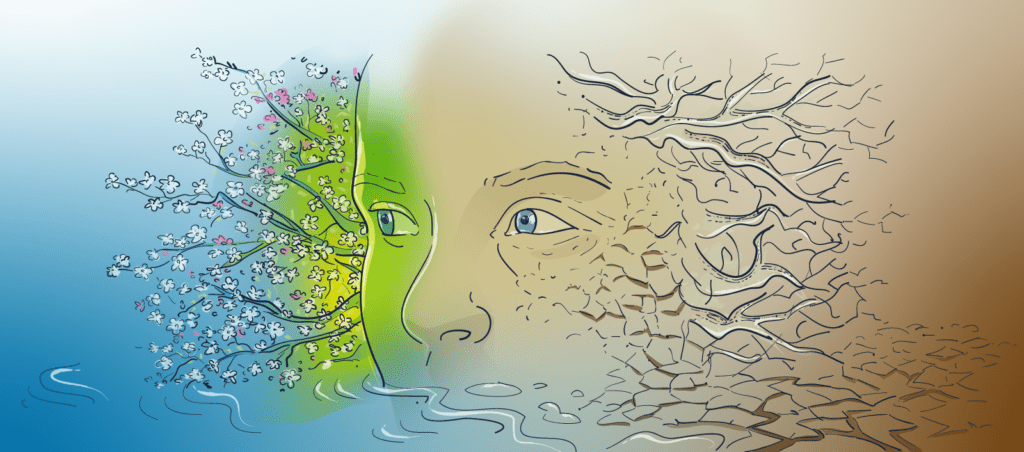|
Ascolta
|
In un mondo sempre più segnato dal cambiamento climatico e dalle tensioni geopolitiche, l’acqua si sta trasformando in una risorsa tanto indispensabile quanto contesa. Una risorsa che abbiamo imparato non essere infinita, soprattutto a fronte di crisi idriche che colpiscono ormai con crescente frequenza intere regioni, compromettendo ecosistemi, economie e stabilità sociali.
In questo scenario, il riutilizzo delle acque reflue emerge non solo come una necessità ambientale, ma come una strategia essenziale anche per garantire sicurezza idrica e ridurre i conflitti legati alla scarsità d’acqua. Una delle sfide cruciali del nostro tempo alla quale risponde anche la nuova direttiva 2024/3019/UE sul trattamento delle acque reflue urbane, entrata in vigore il primo gennaio del 2025.
Acque reflue, definizione e modalità d’uso
In Italia, la definizione di acque reflue è normata principalmente dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (noto come Testo Unico Ambientale), che disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento.
Riassumendo, per acque reflue s’intendono tutte quelle acque che, a causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche, non possono essere scaricate direttamente nei corpi idrici superficiali senza un adeguato trattamento. Queste acque possono provenire da abitazioni, ossia le cosiddette acque reflue domestiche, ma anche da industrie e attività commerciali, come le acque reflue industriali. Oppure ancora, possono essere un miscuglio delle due: in quest’ultimo caso si parla di acque reflue urbane.
Nei sistemi fognari europei, prevalentemente combinati, le acque sono collettate in fognatura e trattate negli impianti di depurazione con processi progressivi fino al livello necessario, dal primario al quaternario, per la rimozione degli inquinanti. Alcune, come i reflui industriali, possono subire trattamenti preliminari prima dell’immissione.
Nel trattamento primario, vengono rimossi solidi e materiali grossolani come oli e grassi tramite sedimentazione e flocculazione. Il trattamento secondario elimina la materia organica, riducendo parametri come la domanda biochimica di ossigeno (BOD), attraverso processi biologici come fanghi attivi e percolazione naturale. Il terziario si concentra invece sulla rimozione di nutrienti, come azoto e fosforo, oltre a batteri e virus, attraverso tecniche di filtrazione avanzata e disinfezione con cloro o raggi UV. Infine, il trattamento quaternario si occupa dei microinquinanti emergenti, come farmaci, pesticidi e PFAS, utilizzando metodi avanzati come ozonizzazione e osmosi inversa.
Solo al termine di questo processo, le acque possono essere reimmesse nell’ambiente o destinate al riutilizzo, trasformando così un potenziale agente inquinante in una risorsa strategica per la sostenibilità e la sicurezza idrica.
Una storia di Direttive Europee lunga 33 anni
L’evoluzione della normativa europea sulle acque reflue negli ultimi 33 anni ha seguito l’urgenza di rispondere ai crescenti problemi ambientali, sanitari e tecnologici. Dalla prima Direttiva 91/271/CE del 1991, che ha introdotto gli obblighi di trattamento secondario per le acque reflue urbane, fino alla recente Direttiva 2024/3019/UE, le regolamentazioni si sono progressivamente rafforzate.
Le nuove norme estendono gli obblighi di trattamento anche agli agglomerati più piccoli, introducono standard più avanzati per la rimozione di microinquinanti come PFAS, farmaci e cosmetici, e incentivano il riuso delle acque trattate per una gestione più sostenibile.
Un aspetto chiave della nuova direttiva è la responsabilità estesa dei produttori (EPR), che impone alle aziende farmaceutiche e cosmetiche di coprire l’80% dei costi di depurazione secondo il principio del “chi inquina paga”.
Inoltre, la direttiva attualmente in vigore incentiva anche la creazione di piani nazionali per il riutilizzo delle acque trattate e stabilisce un traguardo ambizioso: entro il 2045, tutti gli impianti di trattamento dovranno raggiungere la neutralità energetica, riducendo l’impatto ambientale e supportando la transizione ecologica. Per garantire il rispetto di questi obblighi, la normativa prevede scadenze precise per l’adeguamento degli impianti, imponendo agli stakeholder del settore di agire rapidamente per colmare il divario con gli standard europei.
La situazione italiana e due casi virtuosi europei
Abbiamo visto dunque come la nuova direttiva sulle acque reflue urbane nasca da una crescente consapevolezza sull’impatto dei microinquinanti, in particolare dei PFAS, sostanze chimiche persistenti sempre più diffuse nei bacini idrici. Rispetto alla prima normativa del 1991, che non prevedeva trattamenti avanzati, oggi si riconosce la necessità di rimuovere queste sostanze per garantire un’acqua più sicura e priva di contaminanti.
In questo contesto, l’Italia si trova in una posizione critica: molte infrastrutture idriche sono infatti obsolete, e il Paese è già in stato di infrazione rispetto alla direttiva del 1991. Mentre nazioni come Germania e Svizzera hanno investito da tempo in tecnologie avanzate, ottenendo benefici ambientali ed economici, l’Italia deve accelerare gli interventi per adeguarsi agli standard europei.
Due esempi significativi sono il Nordkanal WWTP in Germania e l’Ara Neugut WWTP in Svizzera, che hanno adottato soluzioni innovative per migliorare l’efficienza del trattamento e ridurre l’impatto ambientale. Il caso tedesco mostra come la combinazione di membrane bioreattore (MBR) e carbone attivo in polvere (PAC) abbia migliorato la rimozione di farmaci e pesticidi, ridotto i costi di manutenzione e ottimizzato l’efficienza energetica tramite il recupero di biogas.
Nel caso svizzero, invece, si è riusciti ad eliminare oltre l’80% dei microinquinanti tramite l’ozonizzazione e la filtrazione a sabbia, riducendo la tossicità e abbassando i costi operativi del 20%, con un consumo energetico contenuto. Entrambi gli impianti dimostrano come l’adozione di tecnologie innovative possa migliorare la qualità dell’acqua trattata e favorire una gestione sostenibile delle risorse.
Un duplice vantaggio: la best practice del depuratore di Fregene
Risparmio di risorse naturali, una migliore gestione delle acque e una riduzione dell’impatto ambientale: il riutilizzo delle acque reflue urbane crea un ciclo virtuoso di cui beneficiano sia l’ambiente che l’economia.
Attualmente, il riuso delle acque reflue in Italia è regolato da normative settoriali come il Decreto Siccità e il Decreto Ambiente. Il primo incentiva l’utilizzo delle acque depurate in agricoltura per contrastare la scarsità idrica e ridurre il prelievo dai bacini naturali, mentre il secondo si concentra sul riuso industriale, definendo standard di qualità e promuovendo pratiche sostenibili nei processi produttivi. Questi strumenti rappresentano passi importanti verso una gestione più efficiente delle risorse idriche, anche se manca ancora una normativa organica che disciplini il riuso in modo trasversale.
Pensiamo all’ambito agricolo: utilizzare acque trattate per l’irrigazione dei campi offre agli agricoltori la possibilità di ridurre i costi di approvvigionamento e potenzialmente beneficiare di nutrienti come azoto e fosforo. A tal riguardo, poiché la normativa attuale prevede specifiche soglie di rimozione di questi nutrienti per prevenire l’eutrofizzazione, per sfruttare appieno il potenziale delle acque reflue in agricoltura, sarà necessario un quadro normativo dettagliato che consenta di ottimizzare i processi di trattamento, trattando le acque esattamente quanto basta per bilanciare le esigenze ambientali e agricole, e consentire un riutilizzo efficiente e sostenibile.
Una best practice italiana in questa direzione è rappresentato dal depuratore di Fregene, progetto avviato nel 2023 grazie a un accordo tra il Comune di Fiumicino, il Consorzio di Bonifica Litorale Roma Nord e Acea Ato 2. L’iniziativa, finanziata con oltre 6 milioni di euro dal Consiglio dei Ministri, si inserisce nel quadro delle misure per contrastare la siccità promosse dal Decreto Siccità, che incentiva il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. Il progetto mira a utilizzare le acque depurate per l’irrigazione agricola, riducendo il prelievo di acqua potabile dai bacini naturali e contrastando la siccità. Sebbene il riuso delle acque reflue non sia ancora iniziato, la costruzione di una nuova condotta di adduzione che collegherà il depuratore al canale di bonifica rappresenta un passo cruciale verso l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche.
Ma le acque reflue trattate possono essere impiegate anche in altri settori, come la produzione industriale (ad esempio nei sistemi di raffreddamento o nelle operazioni di pulizia), e in ambito urbano per attività che non richiedono acqua potabile, come l’irrigazione di parchi o il lavaggio delle strade. Inoltre, le acque trattate sono utilizzabili per scopi ambientali, come il ripristino degli ecosistemi naturali, ad esempio per la ricarica delle falde acquifere o per il recupero di zone umide.
Sfide presenti e future
Nonostante i benefici concreti derivanti dal riuso delle acque reflue urbane, le sfide da superare sono ancora molteplici.
Nel settore agricolo, persiste infatti il pregiudizio che l’acqua trattata sia inadatta, nonostante la sua sicurezza e i benefici nutritivi. Superare questa resistenza richiede un forte impegno in termini di formazione e sensibilizzazione.
Agli ostacoli culturali si aggiungono poi quelli normativi ed economici: l’Italia necessita infatti di un quadro regolamentare unificato per evitare frammentazioni che rallentino l’adozione di nuove tecnologie. Il sostegno finanziario statale per gli impianti di trattamento è dunque cruciale, ma deve essere mirato a soluzioni sostenibili.
Infine, nuovi settori industriali, come quello tessile o quelli ad alta intensità idrica, richiederanno un cambiamento di paradigma. In questo senso, la sfida è l’adozione di sistemi di riuso interno delle acque reflue, attraverso la creazione di distretti industriali circolari, per ridurre significativamente l’impatto ambientale e contribuire a un ricircolo virtuoso delle risorse idriche.
Garantire un uso più responsabile e sostenibile dell’acqua è dunque possibile: obiettivo a cui devono concorrere insieme istituzioni, imprese e agricoltori, tramite l’adozione di tecnologie innovative e soluzioni normative adeguate.